Grande emozione per il nuovo film di Panahi, impossibilitato a muoversi da Teheran a causa della condanna del governo iraniano

Dopo “This Is Not a Film” e “Closed Courtain”, con la fine degli arresti domiciliari Jafar Panahi si mette alla guida di un taxi e si prende gioco della sua condanna, o forse più semplicemente cerca di sdrammatizzare la sua condizione di bandito del cinema. Se da un lato è naturale giudicare il film in base alle vicende personali del regista, è anche evidente che la condanna è conseguenza del suo lavoro, sulla sua indagine sui rapporti umani e del potere delle immagini sugli individui e sulla società. Sarebbe un peccato vedere questo film (ed i precedenti) solo nell’ottica della critica e della protesta contro un regime oppressivo e censorio. Il corto circuito per cui un governo si arroga il diritto di decidere quanto la finzione sia “veramente finta”, visto che la verità non può essere mostrata, e sul ruolo dei mezzi di comunicazione di massa in quanto veicoli di verità accettabili, è fin troppo presente anche nelle nostre cosiddette democrazie occidentali, in cui sono le case di distribuzione ad assumersi il ruolo di giudici facendo scomparire film scomodi, cosa che dovrebbe generare un po’ di inquietudine sui rapporti tra libero mercato e governi.
Panahi avrebbe potuto realizzare il suo film totalmente in interni, per dare meno nell’occhio, e invece mostra tutta la città, dal punto di vista di qualcuno che per scelta o per necessità ha bisogno di un espediente per potersi esprimere, e alla limitazione dei contatti risponde con l’ascolto di tante storie e il confronto con tante persone. L’unità del racconto è affidata al taxi, quindi uno spazio limitato, ma anche mezzo con il quale si può andare ovunque, perfetta metafora del cinema. Movimento contro blocco, libera espressione dei sentimenti contro segregazione, in otto capitoli sui differenti usi e ruoli della videocamera nella società iraniana, necessariamente e significativamente senza titoli di testa né di coda.
Le immagini sono ottenute tramite piccole telecamere digitali, al tempo stesso simbolo di libertà ma anche di discrezione, segretezza, controllo. Quanto ai dialoghi, a parte un paio di sequenze, non è mai del tutto chiaro se si tratta sempre di pura improvvisazione e scene di vita reale oppure di finzione ben orchestrata. Questo mix di verità documentaria e messa in scena è chiaramente funzionale al continuo chiedersi cosa è reale, lecito, legale contro cosa è falso, criminale; ed è bene sempre ricordarsi che si tratta del lavoro di un regista che è stato condannato per aver girato dei film e che ci (si) interroga sulla finzione e di come con le immagini sia facile ingannare, soprattutto se lo spettatore (o il governo iraniano) vogliono essere ingannati.
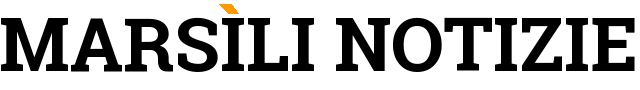 Marsili Notizie Sito di Notizie sommerse e di informazione attiva
Marsili Notizie Sito di Notizie sommerse e di informazione attiva




